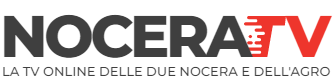Avrebbe potuto essere un «caso» letterario, quello di Corrado Ruggiero, professore nocerino trasferito al nord, che fa il suo esordio narrativo a quasi settant’anni. Ma, si sa, i «casi» sono quasi sempre costruiti a tavolino con accorte strategie e mezzi adeguati, cose che mancano entrambe a quasi tutti gli editori napoletani. E quindi, di Rossa malupina, il romanzo pubblicato da Tullio Pironti nel 2001, si accorsero in pochi. Tra quei pochi, però, c’erano anche lettori molto qualificati, e quindi Ruggiero un piccolo posto nelle patrie lettere se lo conquistò. E il suo ultimo romanzo, Gennarina, è uscito nel 2007 da un editore, Marsilio, di ben diverse dimensioni, e molto gasato dal successo, che già si profilava grandioso, dei suoi «gialli» svedesi. Più che succinta la biografia di Ruggiero, nato nel 1935, laureato in giurisprudenza e in filosofia, a lungo docente in un istituto magistrale e poi preside dell’I.T.C. «Pucci» in quella Nocera che, volente o nolente, si trova ad occupare uno spazio rilevante nelle arti contemporanee, grazie naturalmente a Domenico Rea e all’immortale battuta del povero Stefano Satta Flores nel film «C’eravamo tanto amati» («Nocera è inferiore perché ha dato i natali a gente come voi!»). Diventato poi ispettore scolastico, Ruggiero si trasferì nel 1985 a Milano, dove ha vissuto in tutti questi anni, mantenendo contatti non sporadici con la terra d’origine e con qualche amico letterato. Si è spento ieri per un improvviso accidente cardiaco. I due romanzi citati (ne sono stati pubblicati un altro paio da editori minori) hanno molte cose in comune: Nocera, innanzi tutto, e i personaggi femminili, l’adolescente Assunta Assuntina Assuntinella Assuntulella Suntina di Rossa Malupina e la ragazza Gennarina, che dà il suo nome all’altro romanzo. Il primo si svolge tra gli ultimi anni di guerra e l’arrivo degli americani, il secondo invece in epoca già democristiana, quando certi fenomeni deteriori della vita politica meridionale cominciano a manifestarsi in forme inquietanti. In entrambi la storia principale s’intreccia con molte altre, in una polifonia di grande effetto coloristico, cui dà sapidità il linguaggio, e soprattutto l’uso insistito del dialetto. Così, in Rossa malupina, tutto prende avvio da una scena non inconsueta da queste parti: l’uccisione, nella pubblica piazza, di un noto avvocato del luogo, «che si ritrova all’improvviso spaparanzato a terra, muortacciso per vecchi rancori». Quasi un pretesto, peraltro, perché tutta l’attenzione di chi racconta in prima persona è rivolta alle acerbe grazie della ragazzina, con le fantasie scatenate che suscita in coetanei e adulti. Un personaggio, Assuntina, che ricorda irresistibilmente la «ninfa plebea» di Rea (c’è pure una sorta di piccolo inventario sui diversi modi di chiamare l’organo sessuale femminile), ma che si distacca dal modello soprattutto per il diverso trattamento del materiale narrativo. Approccio caratterizzato, in Ruggiero, da uno sforzo mimetico totale che cerca di riprodurre naturalisticamente – ma non senza scarti improvvisi e rimandi anche dotti – pensieri e comportamenti dei protagonisti. Lo stesso discorso vale anche per Gennarina, in cui il plot è più elaborato e complesso (Gennarina fa parte di una famiglia che ha investito tutte le sue non abbondanti risorse nella carriera politica e professionale del figlio maschio) e ancora più insistito l’uso del dialetto. Perché tutto è visto con gli occhi della protagonista «schiattigliosa. Spruceta. Con una faccia storta dalla mattina alla sera. Accussì era diventata. Ecchì se l’aspettava! Chi lo poteva immaginare!», ma che alla fine nella scoperta del sesso trova una sua personalissima liberazione. Prima di dedicarsi al romanzo, Ruggiero aveva pubblicato scritti di critica e saggistica letteraria, tra i quali mi piace ricordare il volume intitolato Verso dove (1984) che contiene analisi di testi di quattro poeti napoletani (Cavallo, Spagnuolo, Vitiello e l’autore di questo articolo)
Fonte: Il Mattino – Felice Piemontese