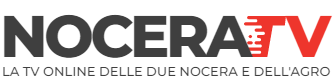65 ANNI FA: L’ULTIMA ERUZIONE DEL VESUVIO
( Informazione e Prevenzione)
Dott. Geol. Giulio Caso
L’ultima eruzione del Vesuvio avvenne nel 1944; precisamente iniziò alle ore 16,30 del 18 Marzo ; dopo che era crollato quasi del tutto il conetto centrale nella notte precedente.
Nello stesso giorno la lava traboccò da una frattura del cono e, dopo aver attraversato l’Atrio del Cavallo, puntò verso Massa e S. Sebastiano.
(Dall’Osservatorio Vesuviano – Sullo sfondo la colata di lava del marzo1944)
La velocità iniziale della lava era elevata (fra i cinquanta ed i cento Km/h), scendendo, rallentò notevolmente e raggiunse, ed iniziò a distruggere, i due paesi il giorno dopo, verso sera.
Dal pendio Ovest, un’altra colata distrusse la funicolare ed attraversò i binari dell’antica ferrovia a cremagliera.
Alle ore 17 del 21 Marzo, sul Vulcano, era iniziata la fase delle fontane laviche che raggiunsero l’altezza di vari chilometri.
Dall’alba del 22 Marzo si sollevarono vapori, sabbie, ceneri, scorie e, soprattutto, lapilli che, spinti dal vento, iniziarono a ricadere, prevalentemente, in direzione Angri, Pagani, Nocera.
A Poggiomarino arrivarono a cadere scorie del peso di 1 Kg. Su S. Giuseppe Vesuviano scorie dal diametro fino a 15 cm.
Da mezzogiorno del 22 Marzo iniziò la fase delle Esplosioni miste con eruzione di frammenti delle rocce vulcaniche che andavano collassando. Si formò una nube che raggiunse i cinque chilometri di altezza.
Un intero stormo di bombardieri americani che aveva bombardato Montecassino e che si trovava in un campo di atterraggio in prossimità di Terzigno venne quasi del tutto distrutto dai lapilli.
(Montecassino, dopo i bombardamenti. Molti degli aerei che avevano partecipato alle missioni, furono, poi, distrutti dal Vesuvio)
(Famiglia in fuga)
Sui paesi intorno al Vesuvio ed in particolare sull’Agro Nocerino i lapilli raggiunsero, in quel giorno, l’altezza media di 80 cm. I cittadini, con il capo protetto alla meglio, spalavano il lapillo dai tetti e dalle terrazze delle case, contribuendo ad elevarne l’altezza per strada che arrivò, in alcuni punti, anche a tre metri.
.
Si rese indispensabile trovare dei luoghi dove raccogliere i lapilli e, nei giorni successivi, furono ricolmati i pozzi, gli ingressi delle antiche tufare, alcuni campi e le vasche di raccolte delle acque e dei fanghi che periodicamente discendevano dai monti (le antiche opere di bonifica del 1806).
Alle ore 14 del 23 Marzo iniziò la fase Sismo-esplosiva con tremori dovuti ai gas che spostavano le rocce crollate e che ostruivano il condotto.
Il giorno 24 una grande nube di cenere chiara imbiancò il cono come dopo una nevicata.
Il 26 Marzo iniziò la Fase finale, le esplosioni diventarono più rade ed il 29 marzo l’eruzione può dirsi conclusa.
Fino alla fine dell’anno si ebbero emissioni di anidride carbonica (mofete) da vari pozzi e dal terreno; queste causarono la morte di altre due persone.
Dal cratere erano fuoriusciti circa 70 milioni di metri cubi di lave. Erano morte decine di persone a causa dello sprofondamento di tetti e solai. (Nota: sarebbe auspicabile, allora, che gli edifici, in alcune zone, fossero progettati con i tetti spioventi). Gli abitanti di S. Sebastiano, Massa e Cercola furono evacuati. I danni furono incalcolabili, ma presto tutto ciò è caduto nel dimenticatoio. Invece bisogna ricordare per studiare sempre più nuove ed efficaci forme di prevenzione, perché un giorno non si ripetano gli stessi errori.
LO "IETTATORE"
Ho frequentato il corso di Fisica Terrestre del Prof. Giuseppe Imbò, alla facoltà di Geologia della Federico II a Napoli. Un giorno, in una pausa della lezione, egli ci raccontò di aver previsto i sintomi dell’ultima eruzione del Vesuvio. Aveva invano avvertito, tra gli altri, gli americani del pericolo imminente. Non fu creduto, o quantomeno, non fu tenuto in considerazione.
Il prof. Imbò non ne faceva un mistero del probabile motivo: i geofisici, come i geologi di una volta, non erano famosi per il loro look. Un capitano, invece, gli diede, i due litri di alcool che egli aveva parimenti chiesto. L’eruzione del Vesuvio, iniziò il 18 Marzo 1944 e si concluse il 29 dello stesso mese. Poco prima dell’alba del giorno 22 fuoriuscirono dal cono principale milioni di tonnellate di lapilli che, spinti dal vento, ricoprirono vaste zone della Campania con danni ingenti e vittime. A Terzigno, i lapilli, distrussero un intero stormo di bombardieri americani che avevano operato nella zona di Cassino, ma l'alcool permise a Imbò di far funzionare il sismografo e di registrare preziosi dati sull'eruzione. Alla fine Imbò ci disse che un alto ufficiale americano aveva, successivamente, chiesto:«Ma chi era quello iettatore?». – << Il direttore dell'Osservatorio Vesuviano>>. Si sentì rispondere.
Giulio Caso
Dopo la caduta dei lapilli, provenienti dal Vesuvio (22 Marzo 44), gli 88 aerei americani, rimasti a terra, nell’aeroporto di Terzigno rimasero quasi completamente danneggiati e sepolti.
Ci furono danni ingenti, e vittime, anche nell’Agro Nocerino.
Nella foto: un aviere americano mentre raggiunge, scavando con le mani, la mitragliatrice di coda di un bombardiere. Questi appartenevano al 340th Bomb Group ed erano i B-25 Mitchell che avevano bombardato Cassino.
I lapilli provenivano da vecchie lave e blocchi frantumati nelle varie fasi esplosive dell’eruzione del Vesuvio; espulsi, poi, violentemente dal condotto del vulcano . Il loro diametro, come si nota dalla foto, generalmente, non superava i tre centimetri, ma sugli aerei caddero anche scorie di 15 centimetri di diametro, che aprirono ampi squarci nelle strutture degli aerei, specie, come si nota, nelle zone di controllo aerodinamico.
(Intervista al Dott. Geologo Giulio Caso)
Escursione sul Gran Cono
D – L’argomento: Vesuvio, c’è qualche motivo particolare per ricordarcene a distanza di 64 anni dall'ultimo evento?
R – Credo che vada considerato, in modo più approfondito, il ruolo dell’informazione nei riguardi dei problemi ambientali; perciò qualunque apporto in tal senso, purché serenamente adeguato alla tranquilla situazione attuale, almeno nel breve periodo, e per quanto riguarda possibili inizi futuri di attività vulcanica, va a beneficio della comunità. Ciò perché una informazione scientificamente valida si rivolge alla razionalità dell’uomo per migliorare, se possibile, i propri progetti in ogni eventualità. Si badi bene, avendo, come abbiamo, il tempo per riflettere, non bisogna aspettare le emergenze per agire. Un vecchio proverbio consiglia: “ Appronta le difese in tempo di pace”. D – Come è iniziata la storia del Vesuvio?
R – Il Vesuvio entrò nella storia con l'eruzione del 79 d.C. (descritta da Plinio il Giovane) che distrusse Pompei, Ercolano, Oplonti e Stabia.
Da allora si sono registrate almeno altre 36 eruzioni di alta intensità. Le eruzioni tra il 1913 e il 1944 sono considerate come la fine di un ciclo eruttivo che cominciò nel 1631.
D – Che relazione c’è fra il Vesuvio e il Somma?
R – Il Vesuvio, o meglio, il Somma-Vesuvio è uno strato-vulcano a recinto, costituito dalla sovrapposizione di materiali e colate laviche, in cui la parte più antica è rappresentata dallo strato-vulcano del Somma e la più recente dal Gran Cono del Vesuvio sorto nella caldera terminale del Somma. Il cratere attuale del Vesuvio è lievemente ellittico e si è formato dopo la fase esplosiva terminale dell'eruzione del 1944.
D – Dal punto di vista vulcanologico, quali sono state le eruzioni più rilevanti?R – Da circa 25 mila anni (pomici di Codola) l’attività vulcanica della Piana Campana è concentrata, in prevalenza, al Vesuvio.La più violenta di tutte fu, forse, quella di 17 mila anni fa detta delle Pomici di Sarno (o Pomici Basali); altre violente eruzioni intermedie e poi 3750 anni fa la cosiddetta eruzione di Avellino (i nomi si riferiscono alle zone di studio dei materiali eruttati). D – Solo le grandi eruzioni del Vesuvio sono pericolose?R – Indubbiamente nelle eruzioni pliniane (come quella del 79 d. C. e grandi eruzioni precedenti) o nelle eruzioni subpliniane (come quella del 1631) le energie ed i volumi (solidi e gassosi) in gioco sono notevoli ed è arduo per chiunque poter valutare con precisione l’area interessata, i rischi sono rilevanti ed è difficile, anche per persone esperte, poter programmare un puntuale piano di emergenza se non prevedendo l’evacuazione di gran parte della popolazione intorno all’area. Per le eruzioni “minori” è più semplice approntare piani adeguati e non eccessivamente traumatici, ma bisogna tener conto di possibili manifestazioni pericolose pur nell’ambito dello stesso fenomeno presentatosi inizialmente in maniera “mite”. Nube ardente D – Ci può fare degli esempi di queste simili manifestazioni?R – Nell’ultima eruzione del Vesuvio (marzo 1944) una nube ardente si spinse a Sud, per due chilometri, oltre l’orlo del cratere; inoltre su Poggiomarino caddero scorie del peso di 1 Kg, mentre a S. Giuseppe Vesuviano, le stesse, avevano diametro fino a 15 cm.
Comunque morirono 45 persone ed altre due furono soffocate dalle successive emissioni di gas dal sottosuolo (mofete) che continuarono per tutto l’anno.
D – Quale fu la causa principale dei decessi?
R- Sia nell’eruzione del 1944 che in quella del 1906 la maggior parte delle persone, nelle zone di ricaduta ceneri e lapilli, perirono per sprofondamento dei solai. Il tipo di costruzione di allora prevedeva solai scoperti (in quella società contadina era diffusa l’usanza di usare i lastricati e le terrazze per essiccare frutta e ortaggi). Ora che questa abitudine non c’è più, forse è giunto il momento di pensare ad una difesa, sia pure passiva, contro questa simile eventualità prevedendo un tipo di costruzione con tetti spioventi, almeno in queste zone.
D – Sinteticamente, qual è la situazione attuale?
R – Dal marzo 1944, il Vesuvio è in stato di quiescenza a condotto ostruito, la sua attività è testimoniata principalmente dalle fumarole. Non si può prevedere quanto tempo durerà questa situazione. Le autorità hanno approntato un piano di emergenza che comprende tutto il territorio. Le numerose stazioni di controllo fanno capo all' Osservatorio Vesuviano, il più antico del mondo, sorto nel 1841, che attua una sorveglianza continua ed efficace.
INFORMAZIONE E PREVENZIONE: VESUVIO
Dott. Geologo Giulio Caso
I vulcani campani, e quelli laziali, hanno avuto origine dalle fratture prodottesi in seguito all’abbassamento dell’area continentale tirrenide. Attraverso le fratture risalì un magma basaltico che, in profondità, formò bacini magmatici isolati che, successivamente, diede origine a vari apparati vulcanici quali: le isole Pontine (nel Golfo di Gaeta); i Campi Flegrei; il vulcano di Roccamonfina; isole di Ischia, Procida e Vivara; il Vulture; il Somma-Vesuvio.Da circa 25 mila anni l’attività vulcanica della Piana Campana è concentrata in prevalenza al Vesuvio, o meglio, al Somma-Vesuvio, in quanto questo si presenta come un tipico vulcano a recinto costituito da uno strato vulcano più antico, il Somma che raggiunse un’altezza di circa 3000 metri, avente una diametro di base di circa 15 km, la cui attività è cessata col collasso della caldera sommitale e dal Gran Cono che è uno strato vulcano più recente il Vesuvio sorto all’interno del primo (eruzione 79 d.C.).Il Vesuvio non è proprio centrato, per cui, col tempo, ha colmato la metà occidentale (verso Ovest) della depressione calderica. Ad Est persiste ancora un ampio tratto della parete di collasso alta fino a circa 300 metri. Circa 8 mila anni fa una serie di lunghe eruzioni fece emergere il Somma Antico dal mare.In sintesi si ha:- L’eruzione di 25 mila anni fa, detta delle Pomici di Codola;Al di sotto delle pomici di Codola troviamo l’ignimbrite campana (tufo grigio) dovuta ai depositi dei materiali eruttati durante le fasi finali parossistiche dell’attività Archiflegrea. Questo fu uno degli episodi che causò la distruzione di quasi tutta la vita vegetale ed animale in gran parte della piana ed oltre (circa 35 mila anni fa), seguita, 12 mila anni fa, dalle eruzione che depositarono il tufo giallo, sempre, principalmente, dai vulcani attivi della grande caldera flegrea. Come detto la deposizione, mediante nubi ardenti, delle ignimbriti campane causò quasi una distruzione di massa. Fu questo un evento importantissimo nella storia geologica della nostra terra, ma un evento più importante stava avvenendo nello stesso periodo: la diffusione dell’homo sapiens.Tutto iniziò con una grande caduta di pomici seguita, poi, da queste enormi nubi incandescenti (inizialmente alla temperatura di circa 800°C che si spostavano, a distanze enormi, alla velocità di 200-300 km/h, esse ricoprirono vuoti morfologici e non solo. Nella zona di Fiano, che ho avuto modo di visitare ultimamente in compagnia del dott. Luigi Papa e del Prof. Abner Colella per un progetto di studio che si svolgerà in Italia e Spagna sulle caratteristiche geomeccaniche del tufo, le nubi ardenti, prima di saldarsi, risalirono la collina fino ad oltre 90 metri sopra il livello di piano campagna antico. La Prof. Barbera, in una precedente visita, ebbe a dire “ è come se si fossero incollate alle rocce”; infatti si trova tufo grigio di Fiano molto al di sopra dello stesso piano campagna attuale (allora 35 mila anni fa era di oltre 40 metri più in basso, la pianura era ricoperta di paludi e le stesse cavità carsiche o comunque ricoveri sotto roccia sono stati ricoperti. Il tufo di Fiano ha assunto caratteristiche particolari. Ritornando alle eruzioni vesuviane;- la più violenta di tutte fu, forse, quella di 17 mila anni fa detta delle Pomici di Sarno (o Pomici Basali); altre violente eruzioni intermedie ed infine: – 3750 anni fa la cosiddetta eruzione di Avellino. (I nomi si riferiscono alle zone di studio dei materiali eruttati).Ed arriviamo a quella del 79 d.C. che distrusse Pompei e che sancisce la nascita del Vesuvio, detta eruzione pliniana, dal nome di Plinio che la descrisse e, comunque con essa, come si dice, il Vesuvio entrò nella storia (e non solo della Vulcanologia).Erano a conoscenza, gli antichi pompeani (romani) del rischio vulcanico dovuto al Somma-Vesuvio loro vicino? La prima risposta che si dà è no! Credo, però, che bisogni articolarla un poco. Il “Vesuvio” ha periodi di quiescenza anche molto lunghi durante i quali è stato facile dimenticarne la pericolosità. Durante la dominazione greca non si hanno notizie di attività (il che significa che non si sono trovati riscontri storici); tuttavia gli antichi greci indicavano tutta la zona dei Campi Flegrei fino al Vesuvio col nome di Campi Ardenti (Campi Flegrei= Campi Ardenti). All’inizio del I secolo, solo pochissimi studiosi romani concepivano la natura vulcanica del Somma-Vesuvio:- Diodoro Siculo, verso la metà del primo secolo a.C. aveva scritto che vi è una montagna chiamata Vesuvio che reca segni del fuoco di un tempo, come l’Etna in Sicilia.- Vitruvio (stesso periodo) “..un fuoco arde sotto la cenere del Vesuvio e talvolta getta fiamme sui campi circostanti”.- Strabone (64 a.C – 25 d. C) “ … la cima improduttiva (del Vesuvio) è color cenere… vi sono rocce porose che sembrano mangiate dal fuoco. Si potrebbe pensare che, in tempi passati questo territorio fosse infuocato e avesse crateri di fuoco e che poi, finito il combustibile si sia spento”. Questo errore di sottovalutazione, purtroppo, anche altre volte, ed in tempi recenti, è stato causa di mancata prevenzione al rischio vulcanico, figuriamoci se era possibile nel 79, anzi nel 62 d. C. perché proprio in questa data si era avuto la prima avvisaglia con un evento sismico di origine vulcanica (come sappiamo oggi) che arrecò notevoli danni fino alle città di Napoli e Nocera.L’ultima eruzione del Vesuvio ha avuto luogo nel mese di marzo del 1944, in piena guerra, ed il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, occupato dagli americani per impiantarvi una stazione meteorologica, era relegato in una sola stanza, eppure riuscì a prevedere l’eruzione in corso e ad avvertire, inutilmente, gli americani per far spostare gli aerei da Terzigno. L’eruzione iniziò il 18 marzo, il 22 marzo 1944, all’alba di quel mercoledì, si riversò sulle nostre zone una pioggia di caldo lapillo che causò circa 45 morti e, successivamente, nello stesso anno, ad eruzione conclusa, altre due morti per le esalazioni di gas (presumibilmente CO2 ) dal terreno (mofete) che durarono tutto l’anno.
Un’altra eruzione che ebbe carattere semipliniano e che causò morte e distruzione fino a Cava e Salerno fu quella del 1631. Da questo periodo il Vesuvio entrò in fase persistente fino appunto all’ultima eruzione del 44 già detta. Precedentemente, nello stesso secolo si era avuta una eruzione con colata lavica (ed esplosioni nel 29) , ma soprattutto l’eruzione del 1906 che causò centinaia di morti per sprofondamento solai.
Il monitoraggio vulcanico del Vesuvio è iniziato nel 1855 quando il direttore dell’Osservatorio Luigi Palmieri, installò il primo sismografo elettromagnetico da lui stesso inventato. Attualmente, oltre alle reti sismiche ci sono vari e moderni sistemi di controlli delle deformazioni del suolo, variazioni campi gravimetrico, geochimici mareografici ecc. Molte notizie sono diffuse in tempi reali e comunque alla portata di qualunque studioso voglia, attraverso internet.Il pericolo principale, non ci si stancherà mai di ripeterlo, nel caso di una eruzione del Vesuvio è dovuto principalmente agli intensi insediamenti abitativi esistenti alle sue pendici. La rete di sorveglianza può egregiamente, in caso di riattivazione del Vesuvio, farci ottenere notizie sul tipo di eruzione, la sua energia, la possibile successione degli eventi e dell’estensione dell’area; un aiuto in questa direzione ci può venire dalla modellistica matematica, ma ci sarà sempre rischio vulcanico potenzialmente elevato se, in contrasto con qualsiasi considerazione di carattere geologico-ambientale, e al più elementare buon senso lasceremo che le costruzioni, più o meno abusive dilaghino ancora intorno al Vesuvio.Il mondo geonaturale necessita di un approccio serio, ben programmato, e nello stesso tempo continuo, nell’importantissimo lavoro di conoscenza, di previsione, di studio e di controllo per poter attuare l’attività di protezione dal rischio vulcanico.